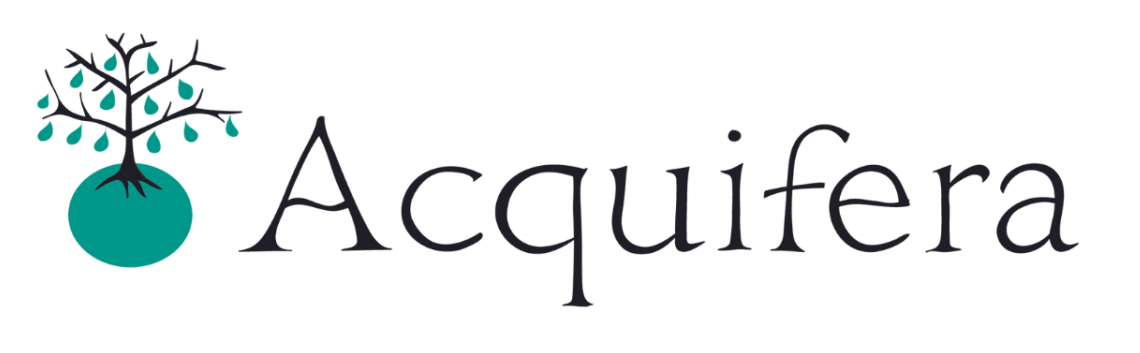Sono appena rientrato da una missione a Loiyangalani, sul lago Turkana, appagato e gratificato per aver raggiunto lo scopo prefissato.
Il Turkana è uno dei laghi della Rift Valley che si distende per quasi trecento chilometri a Nord del Kenya fino ai piedi del grande Altopiano Etiope, verso il delta del Fiume Omo, suo principale immissario: l’Oasi di Loiyangalani è un posto assolutamente “primordiale”, direi quasi dimenticato ma, come tale, assolutamente originale, autentico e….naturale; si è formata per la presenza di sorgenti termo-minerali che si trovano caratteristicamente lungo un allineamento Nord-Sud, dovuto proprio al contatto fra depositi lavici provenienti dal Monte Kulal ed i depositi lacustri dello stesso lago Turkana, ma adesso è proprio “aggredita” dalle condizioni climatiche sempre più impietose che con un sole torrido persistente ed un vento costante sotto forma di brezza o di tempesta di sabbia, favoriscono lo sviluppo della desertificazione e quindi il non mantenimento delle condizioni più idonee allo sviluppo della vegetazione.
La popolazione locale e gli animali sono ormai adattati a questa situazione: in origine nomadi e suddivisi in varie etnie (Turkana, Rendille, Samburu, El Molo), in quest’area sono praticamente diventati stanziali e per la semplice sopravvivenza sfruttano da sempre queste sorgenti o altri affioramenti sorgivi, facendo spesso molti km a piedi per trovare acqua potabile; il lago infatti non si presta a questi scopi in quanto l’acqua è piena di floruri e metalli e a lungo termine provoca danni irreversibili sull’organismo umano.
Non posso non ricordare che l’UOMO è nato proprio in questi luoghi ma nonostante ciò proprio la convivenza in queste “condizioni limite” appare molto difficile e faticosa: risentimenti antichi, diffidenze ormai radicate, rancori sopiti, ostacolano in modo spesso determinante una visione comune di sviluppo e sempre più spesso si è costretti a difendere, anche con le armi, una sorgente o un pozzo per salvaguardare la possibilità di abbeverare le mandrie (unica risorsa di alimentazione e di reddito) o dissetare semplicemente la propria famiglia o la propria tribù.
La ricerca continua di acqua e di nuove fonti di approvvigionamento è diventata una condizione indispensabile, pena uno spostamento di intere popolazioni ed un ritorno concreto al nomadismo come purtroppo sta avvenendo in altre aree africane meno “fortunate”, se mi si consente il termine.
Molto spesso mi sorprendo a pensare e a riflettere su cosa farei io nelle medesime condizioni; come mi comporterei? Come ragionerei? E proprio ragionando che mi rendo conto di come alcuni “usi e costumi” alle nostre latitudini siano assolutamente inaccettabili, di come certi atteggiamenti di sufficienza o di indifferenza siano insopportabili, o di come sempre più spesso siano intollerabili i menefreghismi, le noncuranze o anche le più semplici apatie che possono presentarsi nel nostro paese “civile”!
Il vedere gruppi di donne disposte a fare svariati km a piedi per andare a raccogliere 5 litri d’acqua a testa, sentire i loro canti di accompagnamento durante questa “marcia forzata”, capire la loro “gioia”, la loro tranquillità e dignità ma anche la loro rassegnazione e accettazione di questa apparente situazione di “normalità”, è una cosa che mi ha toccato profondamente.
In quanto geologo forse ho una deformazione professionale o forse, occupandomi da tanto tempo di impatto ambientale, di ricerca idrica, o più semplicemente sentendo più da vicino e toccando con mano il rapporto fra essere umano e territorio sono più “stimolato” a recepire certe situazioni e, devo dire, a volte mi rendo conto di essere diventato decisamente intollerante verso chi certe cose non le comprende o addirittura non vuole comprenderle.
Fortunatamente, alcune situazioni cercate e rinvenute in contesti molto differenti dai nostri contribuiscono a “placare” questa intolleranza e gratificano in modo molto pìù appagante di quello che si potrebbe pensare. Loiyangalani, ad esempio, è uno di quei casi, una di quelle situazioni…..i cui risultati acquisiti ben corrispondono e ben ripagano tutti gli sforzi fatti per raggiungere l’obiettivo! Ma non è questo il solo, perché in molti altri contesti, non soltanto in Africa, spesso alcune condizioni si ripresentano e soltanto un corretto approccio professionale consente di giungere alla risoluzione del problema, senza dover ricorrere necessariamente a conclamati o pubblicizzati gesti di beneficenza o di “solidarietà”.
Premetto, infatti, che in nome di questa solidarietà, in nome della misericordia o della semplice compassione, si sente molto spesso parlare di aiuti umanitari o di cooperazione, ma altrettanto spesso certe cose si riducono al semplice “assistenzialismo” ed anche nelle situazioni più accreditate magari non è presente una condivisione con le comunità locali ed un rapporto tale da consentire la buona riuscita dell’aiuto offerto o del lavoro svolto; molto spesso alcune scelte apparentemente “costruttive” possono addirittura risultare controproducenti e far ripiombare nelle difficoltà quella popolazione o quegli individui che si tentava di aiutare. La buona fede da sola non basta, la “voglia” di portare assistenza e aiuto, da sola non è certo sufficiente…è necessario quindi soffermarsi a “studiare” il problema in questione, con tutte le capacità tecniche che abbiamo, senza star dietro a strumentalizzazioni varie o a principi dettati dai condizionamenti economici.
In pratica a fare un “buco per terra” con la visione di “aiuto umanitario” sono capaci tutti ma limitarsi a quello, a mio modo di vedere, non può considerarsi un vero e proprio aiuto in quanto il degrado, la miseria e le malattie risultano talmente sviluppate in questi posti che l’operazione rimarrebbe fine a se stessa e non costituirebbe una vera e propria soluzione. Invece, studiare il problema in modo approfondito, utilizzare strumenti adeguati per la ricerca e la realizzazione dell’opera, mettersi in gioco professionalmente per aiutare quella determinata popolazione a crescere e a svilupparsi in piena autonomia e libertà, deve essere necessariamente tradotto come “cooperazione” a tutti gli effetti e sicuramente costituirebbe il valore aggiunto per rendere indipendente e pienamente autonoma tutta la popolazione coinvolta nel medesimo progetto.
L’acqua rappresenta, in questo caso, il fondamentale primo aspetto da cui partire per realizzare questo tipo di progetti. Comprendere come funzionano i meccanismi di circolazione idrica nel sottosuolo vuol dire comprendere come sarà possibile in seguito organizzarne al meglio lo sfruttamento e come affrontare contestualmente l’azione di formazione e di convincimento da svolgere fra i vari gruppi etnici, considerandola allo stesso modo importante e decisiva.

Utilizzare tecnologie di indagine relativamente sofisticate per la ricerca idrica, ormai largamente sperimentate, in grado di darci risultati straordinariamente utili per la ricostruzione dei vari accidenti del sottosuolo, è cosa per noi alquanto “normale”, al fine di ottenere una gamma di informazioni vasta e diversificata da utilizzare al meglio e spesso, in modo risolutivo. Perché nella quasi totalità dei progetti di cooperazione e di aiuto, ciò non viene fatto? Bisogna convincersi che è inutile andare a cercare l’acqua dove ci fa comodo; sottoterra l’acqua si muove seguendo regole precise all’interno di strutture geologiche particolari che sta a noi individuare per ottenere i migliori risultati in termini di qualità e di quantità.
Prendere finalmente atto di questo, potrebbe aiutare a condividere il principio sacrosanto che l’acqua è un bene comune da dividersi con equità e nel rispetto di precisi principi di salvaguardia.
È una scommessa che vale la pena di fare perché in certi contesti la posta in gioco è enormemente alta.
Non si può continuare a procedere a caso, nessuna giustificazione è più possibile.
Marco Folini